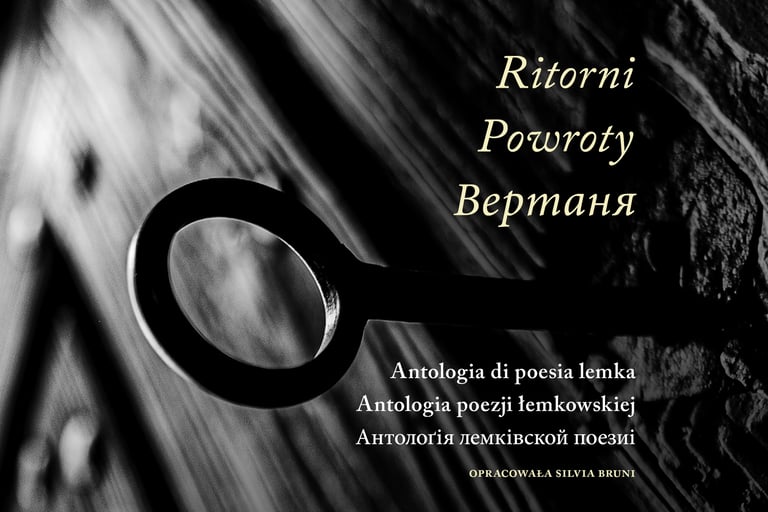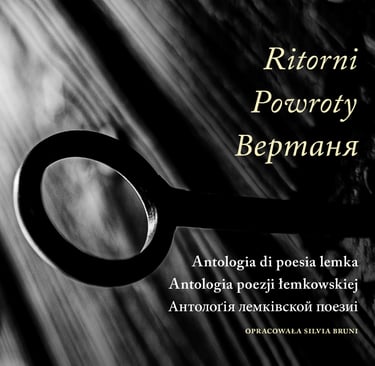Ritorni
La comparsa di un'antologia di poesia Lemka
POESIA INTERNAZIONALE
Francesco De Luca
12/28/202311 min leggere


La poesia è come l'acqua. Per quanto venga relegata sugli scaffali più nascosti o negli angoli delle librerie, per quanto i poeti vengano esiliati o volontariamente ignorati, essa sgorga. Nei luoghi e nei modi più impensabili. Attraverso carne e ossa, sguardi e canzoni.
È questo il caso di questa piccola, e preziosa antologia di poesia Lemka, a cura di una ispirata Silvia Bruni, pubblicata da Austeria, storica casa editrice polacca, di base a Cracovia, con una sede nella nostra amata Siracusa. A Ortigia.
Questo volume, copertina grigia e bianca, presenta - almeno al sottoscritto - una poesia che non esiste. Di cui ignoravo l'esistenza. La poesia di una etnia che non esiste. Ciò fa di loro ancor più poetica la poesia. L'etnia Lemka. Un popolo violentato. Sradicato dalla violenza dell'uomo, come avviene ancora oggi, in altre parti del mondo.
Un popolo intero deportato. Il nome dell'operazione? Operazione Vistola (Akcja Wisła), con cui il governo comunista polacco, appoggiato dall'Unione Sovietica e dalla Cecoslovacchia comunista, nel 1947, spostò circa duecentomila persone costringendole a lasciare la propria terra, al confine sud-orientale della Polonia, per stabilirle ad ovest. Non lontano dalla Germania. Nei nuovi territori acquisiti a seguito della Seconda Guerra Mondiale.
Ma lascio la parola alla curatrice di questo prezioso volumetto, per cui La Chimera vuole solo farsi carta. Carta per ravvivare ancora, tra carbone e pezzi di legno, il fuoco nelle stufe della poesia.
"La comparsa di un’antologia di poesia lemka incentrata sul repertorio successivo all’Operazione Vistola costituisce per me un evento culturalmente ragguardevole che segna l’approdo del nostro universo sensibile in un nuovo ambiente ricettivo. Ciò non può che suscitare un profondo senso di soddisfazione e apprezzamento. Da studiosa e divulgatrice della letteratura lemka non‑ ché scrittrice in seno alla medesima, ho accolto con decisa approvazione l’idea a monte del progetto e ne ho sostenuto l’autrice, Silvia Bruni, contribuendo, fin dove riuscissi, alla sua realizzazione. Appaga e accresce il mio entusiasmo la consapevolezza che a prendere in mano questo volume sarà un lettore deciso a raggiungere un mondo distante, ma per certi versi anche vicino. Sono infatti convinta che chiunque abbia un’inclinazione alla poesia possieda per natura una particolare intuizione sensibile rivolta alle immagini, alla metafora, e che sia dunque capace di una profonda empatia nell’accogliere l’Altro. Egli accederà al nostro mondo: ad una realtà non facile da comprendere, profondamente scossa, ma al contempo dolce e immersa in un’esistenza compenetrata dalla natura e dal mito. Accogliendo il lettore in questo mondo desidero pronunciare, sulla soglia di un’escursione attraverso la poesia, alcune parole di iniziazione alla sostanza spirituale della nostra lirica che servano ad oltrepassare la soglia con prudenza e ad intraprendere il cammino con una motivazione fondata: i sentieri che egli ha dinanzi non sono stati ancora spianati e restano tuttora inaccessibili a molti, attendendo viaggiatori sensibili, desiderosi di raggiungere angoli di mondo lontani da strade asfaltate, pronti ad essere scoperti, preparati al delicato incontro.
Se la domanda derridiana Cos’è la poesia? venisse posta in riferimento alla lirica lemka postdeportazionale, una delle prime risposte suonerebbe – una lotta tenace. Questa, a sua volta, susciterebbe una serie ininterrotta di domande che, esauriti deter‑ minati argomenti, aprirebbero al contempo un dialogo su ulteriori questioni. Un’eco della lotta sopra richiamata è, nel nostro caso, l’incompimento – un concetto profondo quanto quello di realtà, ambivalente quanto quello di vita, appartenente ad una complessa famiglia semantica in cui morire è consanguineo di compiere, ma anche finire, proseguire, costruire. All’essenza di tali 8 9 accezioni giace un compimento, un costruire senza sosta. L’eventuale presenza del prefisso di negazione ‘in’ è sintomo di una spaccatura, una crepa, un’interruzione verificatasi nel processo di durata, nel corso della vita. Poco più di settanta anni or sono il mondo lemko subì infatti una frattura che per tutti gli autori qui presentati costituisce la realtà preponderante di ogni giorno, inalienabile, viva nelle coscienze sebbene da tempo assimilata. Negli anni 1945-1947 si assistette alla scomparsa di un universo di persone le cui radici affondavano lungo i dolci declivi del Beskid Niski e che qui avevano creato un universo fondato sui concetti‑valore di patria, amor patrio, Łemkowyna. Una politica unificatrice condotta senza compromessi, volta a neutralizzare la varietà culturale del paese, riuscì allora, in vario modo, a sradicare le comunità indigene. Ai Lemki spettò una delle soluzioni più impietose: l’abbandono forzato dei monti nativi e il trasferimento in Ucraina e negli ex territori orientali della Germania annessi alla Polonia dopo le due guerre mondiali. L’assimilazione così pianificata raggiunse gli effetti sperati non dimostrandosi tuttavia fino in fondo efficace.
Tocchiamo dunque direttamente la lotta cui si è accennato sopra. La poesia riesce non solo a definire lo stato di fatto della realtà lemka nel modo più completo e viscerale, ma anche, in virtù della sua portata performativa, a resistere alla scomparsa. Ogni comunità che subisca dislocazioni, trasferimenti, si trova costretta ad inseguire il proprio ideale di reinvenzione, a raccontare, esprimere se stessa in maniera sempre nuova, nel mito, nella narrazione. La reinvenzione lemka poggia fondamentalmente sulla lirica, che in rapporto alla dislocazione forzata assurge a simbolo di diniego, per cui i territori meta del trasferimento sono tuttora ‘terra straniera’ (чужына). Figura essenziale del diniego è l’antitesi Łemkowyna = sacrum – esilio = profanum.
Tutti i poeti presentati in questo volume appartengono alla corrente da me definita dell’autopresentazione lemka: oltre‑ passano la barriera dell’isolamento protettivo aprendosi al lettore esterno e recuperando per la Łemkowyna il tempo futuro. Tutti vivono e creano in patria, alla quale hanno fatto consciamente ritorno dall’esilio, confrontandosi ogni giorno con le conseguenze dello sradicamento sociale e le implicazioni del durare per virtù naturali. Ciò dà loro la forza e il coraggio di aprirsi. Anche per tali ragioni, ciò che nei loro brani tocca questioni di ordine storico, reca il segno del trauma, del dolore, della consapevolezza della devastazione, della rovina. Per contro, ogni riferimento alla terra, alla natura, nonché allo spirito e alla volontà degli avi, è rimando ad un’entità perenne, incorruttibile, rinascente. Da qui la mia scelta di definire la poesia lemka poesia del dolore, ma anche poesia della ricostruzione della propria dimora. Suo paradigma è l’ethos del durare, del resistere. È una lirica che penetra, e con lei i suoi lettori, negli strati culturali della tradizione, di cui saggezza e immaginario folclorico costituiscono da sempre i capisaldi, tenendo simultaneamente lo sguardo puntato al domani della Łemkowyna. Quest’ultimo appare incantato nel “sarà” di Paweł Stefanowski, nel concetto di rinascita (“ecco la mia nuova casa / mia come il respiro”) evocato da Graban; nel desiderio che presenzia ai versi di Murianka; nella speranza declinata nelle mie poesie. È un repertorio che commuove e al tempo stesso induce ad una riflessione profonda; la dissonanza, la rottura predominano sull’armonia e sull’aggregazione. Come un fiume carsico scorre perennemente la domanda su come progredire – su “come potrà esser meglio?”.
È questo il mio sguardo da partecipante interno impegnato nella lotta per resistere. Dietro mio suggerimento sono en‑ trate a far parte di questo volume alcune delle poesie che più acutamente esprimono le aspirazioni di cui si è detto sopra. Un sentiero di scoperta in parte divergente è stato seguito dall’autrice del progetto. Essa ha ricercato quanto potesse restituire la Łemkowyna che lei ha conosciuto e vissuto attraverso racconti, immagini e il contatto diretto con il paesaggio, manifestando al contempo l’individuale sensibilità di ciascun poeta. Per me il suo sguardo è molto prezioso poiché consente di stemperare almeno in parte il saldo imperativo che io stessa serbo, rispecchiando non tanto i bagliori derivanti dalla spaccatura quanto invece i contorni di un’immagine artistica e spirituale sorprendentemente omogenea. In questa prospettiva le personalità artistiche degli autori vanno ad integrarsi, completarsi a vicenda sotto uno sguardo inedito, senza che con ciò ne vada perso il valore precipuo, ne venga alterato il significato, il quale risulta anzi approfondito.
Dunque Paweł Stefanowski, che la mia penna critica definisce il poeta più dichiarativo, manifestativo e narrativo ad un tempo, colui che per primo ha posto in luce la questione dei Lemki rivendicando il loro diritto ad un trattamento umano, spinto ad agire dall’intimo imperativo di dover raccontare, spiegare, mostrare “com’era, com’è” e come “dev’essere”, agli occhi della curatrice del volume appare altresì nelle vesti di sottile cantore del sentimento rivolto alla donna, espresso attraverso l’inconfondibile cifra paesaggistica lemka.
Petro Murianka ci consegna innanzitutto una lirica patriottica gonfia di emozioni fino al dolore, cui si è scelto di affiancare travolgenti espressioni di un senso del sacro che racchiude l’attaccamento a Dio, alla terra, agli avi.
Władysław Graban, straordinariamente sensibile alla bellezza e ai ritmi della natura è, ai miei occhi come a quelli della tra‑ duttrice, il poeta dell’unità cosmica pulsante di vitalità, del vibrare delle emozioni e del vento, che tocca la vita quanto la storia.
Stefania Trochanowska, altrettanto indivisibile nella sua femminile etereità, nei sensuali rapimenti in seno alla natura, nell’intima riflessione, nella laconicità e nell’esposizione essenziale dei concetti, appare sotto una prospettiva affine a quella che io stessa avrei valorizzato.
Infine, la mia personale tensione verticale ha assistito ad una differenziazione e ripartizione in fasci di pensiero, giochi linguistici, al risalto della negazione nella sua essenza, in un continuo approfondimento di concetti secondo un movimento circolare, ininterrotto. La selezione qui proposta reca quindi accenti in parte diversi da quelli che riterrei più tipici della mia autorappresentazione.
Il presente volume offre una duplice prospettiva: una visuale interna – creativa, analitica, identitaria, ed una esterna – appartenente al lettore, estetica, universalizzante. Non ho dubbi che la curatrice abbia compiuto ogni sforzo per rendere il nostro mondo quanto più ampiamente accessibile al lettore italiano. Un mondo certo distante, ma anche, ne sono certa, vicino e travolgente per il suo tendere all’autorappresentazione e la sua forte volontà di resistenza a dispetto del tempo. Ringrazio dunque sentitamente la dottoressa Silvia Bruni per il proposito perseguito, la fermezza nel realizzarlo e lo splendido compimento, il quale non può che appagare e commuovere. È mia speranza poter condividere con i lettori questo stesso apprezzamento."
Cracovia, 20.03.2022 Olena Duć‑Fajfer
(Traduzione di Silvia Bruni)
Il mio mondo (di Władysław Graban)
Il mio mondo è piccolo
come la culla di un bambino
uno steccato sul fiume
un sentiero battuto
Ogni giorno vado alle terme
cerco le origini dei patriarcali
cardi piumati tocco
pastrani di covoni campestri
Il mio mondo è piccolo
come un cortile di campagna
una gru davanti alla capanna
una finestra piena di rondini
Cerco le radici degli antenati
che intrecciano le viscere della terra
col pesante respiro del cuore
col muto ciottolio dei sassi
Il mio mondo è piccolo
ancor più d’una foglia d’acero
e sebbene siano passati anni
cerco ancora la mia dimora
Świat mój
Świat mój jest mały
jak kolebka niemowlęca
poręcz nad rzeką
wydeptana ścieżka
Chodzę co dnia do zdroju
źródeł szukam ojcowych
pierzastych ostów dotykam
sukmany polnych chochołów
Świat mój jest mały
jak podwórko wiejskie
żuraw przed chatą
okno jaskółek pełne
Korzeni szukam pradziadów
co oplatają trzewia ziemi
z ciężkim oddechem serca
z niemym łoskotem kamieni
Świat mój jest mały
mniejszy od liścia klonu
i choć minęły lata wciąż
szukam własnego domu
La mia poesia (di Władysław Graban)
La mia poesia
racchiuderà in sé
il volo impetuoso della rondine
imprigionata in una pozza di fango
porte socchiuse
d’una casa di nessuno
e poche foglie d’ortica
intrecciate
in una corona senza gloria
sarà una stella indecifrata
dell’emigrazione
La mia poesia
sono pochi sospiri
di nessuno
Mój wiersz
Mój wiersz
zamknie w sobie
lot śmigłej jaskółki
w błotnistą kałużę uwięzionej
niedomknięte drzwi
chaty niczyjej
i kilka liści pokrzywy
w wieniec bez chwały
uwity
będzie nieodczytaną gwiazdą
wychodźstwa
Mój wiersz
to kilka westchnień
niczyich
Senza titolo di Olena Duć-Fajer
Il mio mondo
non è una parola altrui
è una particella di spazio
nell’assoluto
una preghiera
per le anime morte
che covano ancora nella terra
una luce verde
per i secoli a venire
radicati
nell’archetipa
immagine della vita
Mój świat
to nie cudze słowo
to cząsteczka przestrzeni
w absolucie
modlitwa
za umarłe dusze
które jeszcze tleją w ziemi
zielone światło
dla idących wieków
archetypem
wkorzenionych
w obraz życia
Ai Polacchi (di Paweł Stefanowski)
Non eseguo ordini
tengo le redini della mia fantasia
tra fruscii
di foglie acerbe
nel folto
di strani scuri arbusti
cerco il sentiero
del cuore fraterno dei Polacchi
del cuore familiare
ai Lemki
Vado alle querce dei Lechiti
con la bibbia
dei secoli lemki
una piccola folla
si stringe attorno a me
adagiando tronchi di tiglio
assume le forme di una massa
Vado
alle querce
con un ramoscello di rovere di Drzymała
semplice
sincero
sottile
Do Polaków
Nie robię na zamówienie
trzymam fantazji mej cugle
wśród szmerów
niedojrzałych liści
w zaroślach
dziwnych ciemnych krzewów
szukam ścieżyny
bratniego serca Polaków
rodzimego serca
Łemkom
Idę do dębów Lechity
z biblią
łemkowskich wieków
tłum mały
mnie wchłania
ścieląc lipowe kłody
w wielki tłum się stacza
Idę
do dębów
z dębową gałązką Drzymały
zwykły
szczery
mały
Dopo la diaspora del gruppo etnico, la lirica lemka ha espresso con toni ineditamente forti, oltre che autentici e variegati, l’assoluto e incondizionato attaccamento alla terra delle origini, l’amata Łemkowyna – per le carte geografiche Łemkowszczyzna. È essa al contempo “universale, partecipe di tutto quanto sia umano: di ogni cosa possa commuovere individui di qualsiasi nazionalità e lingua”. La sublimazione del rimando al fatto storico e ai suoi risvolti più intimi e particolari messa in atto dagli autori è compiuta a decantare i principi morali a fondamento del riscatto del male di ogni tempo: il rispetto per il prossimo, l’amore per il creato, il senso del sacro.
Nasce da qui la decisione di consegnare al lettore questa parte del repertorio poetico lemko, in un’antologia volta a farne approdare in Italia i primi saggi. Di questo patrimonio letterario – monito a favore di un comportamento etico salvifico per l’umanità – e dell’intera comunità lemka costituita oggi da alcune migliaia di individui, si intende contrastare l’oblio trasmettendone i valori più caratteristici ben oltre i confini geografici originari e invogliando ad una loro più approfondita conoscenza.
Fanno da contrappunto ai brani scatti paesaggistici nonché dettagli architettonici, elementi del folclore e momenti di vita quotidiana immortalati dalla penetrante e ricettiva sensibilità di Simona Ottolenghi e Roberto Gabriele nella terra patria di Nikifor ed Andy Warhol.
Silvia Bruni (dalla Postfazione)
Francesco De Luca (1979), poeta, scrittore, traduttore ed editore romano. Mediatore di Lingua e Cultura Cinese. Si laurea in Comunicazione presso la Sapienza di Roma, nel 2004. Ha pubblicato Anomalie (2015), Karma Hostel (2019) ed è presente nell'antologia Roman Poetry Festival (2019); ha tradotto Un Uomo Felice, poesie scelte di Haizi (2020), Io e l'Italia, di Liu Xi (2022), Poesia Celeste, di Hei Wen (2023), Lo Scenario Invisibile. Mente, Allucinogeni e I Ching, di Terence e Dennis McKenna (2024).